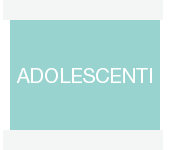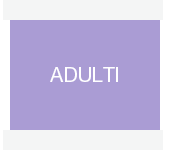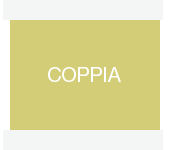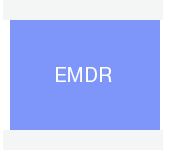Languishing: l’emozione in cui non si provano emozioni - dicembre 2021
Se c'è una cosa che il Covid-19 ci ha insegnato è che, in
qualsiasi momento, la nostra vita può cambiare.
Con la pandemia abbiamo scoperto che la solita routine, considerata acerrima
nemica, in fondo faceva funzionare le nostre esistenze grazie a un meccanismo
ben collaudato. Invece la quotidianità di tutti i giorni, a tratti soffocante e
che accusavamo di essere noiosa, di colpo è crollata su se stessa.
Quando la pandemia è entrata nelle nostre vite, in maniera dirompente e
inaspettata, le emozioni e gli stati d’animo più diffusi sono stati ansia,
rabbia. paura. La paura: un'apprensione forte, devastante e invisibile.
Gli studi riportano che, a oggi, la maggior parte della popolazione ha imparato
a gestire tutto questo, ma ciò non significa che le persone stiano bene o siano
addirittura appagate. Né felici, né tristi.
Nel 2005 lo psicologo e sociologo Corey Keyes , docente alla Emory University in
Georgia, ha coniato per la prima volta il termine languishing per definire uno
“stato di vuoto e stagnazione” che indica l’apatia e la rassegnazione di fronte
alla realtà e che rimanda a un’inattività devitalizzante senza benessere, né
scopo, né vivacità.
In Italiano possiamo tradurlo con “languire”, che secondo il Vocabolario
Treccani significa “essere privo di forze, essere in uno stato prolungato di
abbattimento fisico” oppure “venir meno, scemare, indebolirsi perdendo
intensità”.
Ciò che molti individui provano in questo momento, in particolare come reazione
al periodo di pandemia così prolungato, non è depressione o tristezza ma
mancanza di gioia e di scopi.
Nel suo articolo per The New York Times, Adam Grant, uno dei più autorevoli
psicologi americani e docente alla Wharton Business School della University of
Pennsylvania, sostiene che tale stato di malessere è presente nella popolazione
statunitense molto più della Depressione Maggiore e come la persona che si trova
in questo stato non riesce a percepire che sta lentamente cadendo nella
solitudine, e nemmeno il fatto che a poco poco si ritrova immersa
nell’indifferenza della propria indifferenza, senza una consapevolezza rispetto
a ciò che le sta accadendo.
Il pericolo è che questo stato di malessere rischia di passare inosservato,
perché non comporta particolari sintomi, ma è uno stato che gradualmente “
spegne” le persone e ne distrugge le loro motivazioni, le funzioni e le loro
capacità personali.
Il languishing in Italia è un termine utilizzato in modo forse un po’ improprio
perché, o è traslato dalla cultura americana a quella italiana, o viene
menzionato in relazione ad altri disturbi (quali ad esempio il disturbo
bipolare), ma di cui il collegamento non ha evidenze scientifiche.
In questo momento non ci sono molte ricerche italiane che approfondiscono questo
stato emotivo e lo correlano con il periodo pandemico.
Alcuni spunti interessanti provengono da ricerche più settoriali, finalizzate a
esaminare il rapporto tra languishing e Disturbo Post Traumatico da Stress
riguardo alla pandemia. E’ stato rilevato che, nella primavera del 2021, le
persone colpite dallo stato di languishing in Italia probabilmente erano tre
volte di più di quelle cui era stato diagnosticato il Disturbo Post Traumatico
da Stress.
Senz’altro, però, è utile riflettere sull’utilizzo di tale termine, poiché non è
infrequente incontrare persone che si trovano in questo stato di progressivo
appiattimento dovuto a un impoverimento di stimoli e di relazioni sociali che
l’avvento del Covid-19 ha comportato.
E’ necessario evitare di fare confusione e porre l’accento sulle differenze tra
personalità depressiva, disturbo depressivo e languishing.
Quando si parla di depressione si può far riferimento sia a una personalità
depressiva sia a un disturbo di personalità; mentre nel caso del cosiddetto
languishing si parla di stato emotivo.
Nel caso della persona con una personalità depressiva, l’affetto caratterizzante
è questa grande e palpabile tristezza che la caratterizza e, anche nei casi in
cui non si sente particolarmente giù di tono, trasmette all’altro comunque una
“profonda malinconia interiore” (Mc Williams N., La diagnosi
psicoanalitca, Astrolabio Ubaldini, Roma, 2011).
Un aspetto centrale di una struttura depressiva sta nel fatto che si è
profondamente convinti, spesso inconsapevolmente, di essere intrinsecamente
distruttivi e, quindi, di essere meritevoli di rifiuto e anche di averlo
provocato. Oppure, dall’altro lato, si è convinti di essere sempre inadeguati,
desiderosi dell’affetto degli altri ma condannati a una vita di delusione,
perché non ci si sente voluti né meritevoli di amore.
Le persone con questo stile di personalità si possono sentire vuoti, soli e
deboli e sentire che la loro vita è incompleta e priva di significato.
Per quanto riguarda il disturbo depressivo secondo il PDM-2 (Lingiardi V., Mc
Williams N. La diagnosi psicoanalitica. Seconda edizione riveduta e ampliata,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020 ) chi ne soffre, oltre a caratterizzarsi
per una disposizione a sentirsi in colpa e/o provare vergogna, è colpito anche
da sintomi vegetativi (quali il rallentamento psicomotorio, mutamenti
dell’appetito, disturbi del sonno e diminuzione del desiderio sessuale o del
piacere sessuale) e dalla presenza di un affetto disforico (la persona si sente
triste, inquieta, frustrata, tesa e irritabile).
Nel caso dello stato emotivo del languishing, invece, esso non sembra colpire
esclusivamente persone con una struttura depressiva di personalità, né chi
soffre di depressione, ma può invece caratterizzare persone differenti tra loro.
Nessuno è immune dal languishing tuttavia sono stati identificati dei fattori
protettivi e dei fattori predisponenti. Le persone più abili nella gestione
dello stress sarebbero meno inclini a “languire”, poiché meno predisposte a
farsi sopraffare dagli eventi. Al contrario, soggetti con predisposizione
genetica a patologie psichiatriche, o con precedenti disturbi d’ansia o
depressione, sarebbero più inclini a sviluppare tale stato emotivo.
Anche i soggetti particolarmente estroversi potrebbero incorrere in questa
emozione, poiché potrebbero risentire particolarmente delle restrizioni e
all’assenza di socialità dovute alla pandemia.
Forse ciò che rende ancora più complesso il languishing è l’impossibilità di
attribuire un nome, di riconoscere, e, di conseguenza, gestire, quest’ assenza
di benessere.
Come nella gestione di tutte le altre emozioni, la consapevolezza di ciò che
stiamo vivendo può aiutarci a farvi fronte, ad attraversare la tristezza, la
rabbia, la paura, consci che ne usciremo, che finirà.
Adesso ci troviamo di fronte a una nuova sfida, connessa a quella affrontata
sino a qui: si tratta della sfida della ripartenza, che non significa tornare al
mondo così come lo abbiamo lasciato prima della diffusione della pandemia, ma
imparare a coesistere con il virus, attraverso una lenta e graduale ripresa
delle principali attività lavorative e sociali, senza mai dimenticare le
precauzioni sin qui adottate.
Si tratta di trovare una rinnovata capacità di adattamento, non più
all’isolamento ma alla convivenza con il virus, che richiede la capacità di
essere flessibili.